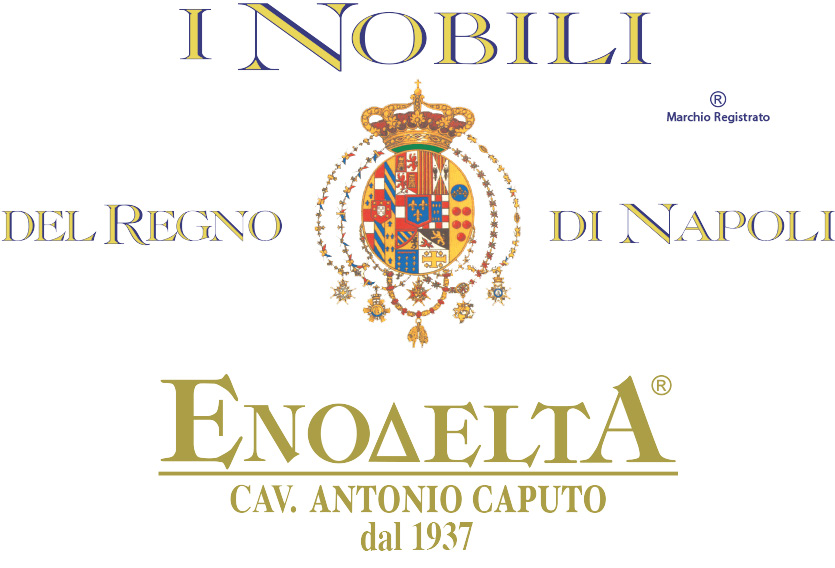Di Massimiliano Del Prete
Uno dei temi, costantemente, al centro del dibattito politico e sociale è l’inclusività, legata indissolubilmente al superamento dei pregiudizi razziali e delle disparità di trattamento.
Il discorso deve necessariamente essere affrontato da un punto di vista culturale e storico il che presuppone la conoscenza dei motivi e delle strumentalizzazioni pseudo scientifiche e politiche che, da sempre, sono state attuate in maniera manipolatoria per condizionare le dinamiche sociali.
Il Museo di Antropologia di Napoli, situato nel cuore del centro storico presso il complesso universitario di Via Mezzocannone 8, è una gemma nascosta tra le istituzioni culturali della città e rappresenta un polo espositivo che ci aiuta a viaggiare a ritroso nel tempo per comprendere quali siano i meccanismi alla base della generazione della discriminazione razziale e quanto invece sia meravigliosa la biodiversità antropologica.
La Dott.ssa Lucia Borrelli, Direttrice del museo, ci ha accompagnato alla scoperta delle straordinarie raccolte esposte illustrandoci, con la competenza che caratterizza chi studia un argomento che lo appassiona, i vari reperti in mostra.
Ma partiamo dalla storia del Museo. Fondato nel 1881 per volere di Francesco De Sanctis, allora ministro dell’Istruzione del Regno d’Italia, il museo è parte del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II e custodisce oltre 26.000 reperti che raccontano l’evoluzione biologica e culturale dell’umanità, con un focus particolare sulla paleobiologia e la preistoria delle popolazioni dell’Italia meridionale.

Il museo nasce nel 1881 come “Gabinetto di Antropologia” grazie all’opera dell’antropologo ed etnologo Giustiniano Nicolucci, primo direttore e docente di Antropologia dell’ateneo napoletano, contemporaneamente all’istituzione della Cattedra di questa disciplina a Napoli, una delle prime in Europa.
Le pregiate collezioni private, raccolte durante anni di campagne di studio, costituiscono il nucleo originario del patrimonio museale. Tra il 1890 e il 1921, il museo acquisì notorietà grazie al lavoro di studiosi come Abele De Blasio e Vincenzo Giuffrida Ruggeri, ma attraversò periodi difficili a partire dagli anni ’30. La soppressione della cattedra di Antropologia durante il regime fascista e i danni causati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale portarono il museo a un lungo periodo di chiusura e abbandono, con molti reperti relegati nei depositi universitari. Solo nel 1950, grazie all’intervento del biologo Mario Galgano, le collezioni furono salvate dalla dispersione, e il museo fu riaperto al pubblico nel 1994, riconquistando il suo ruolo di centro di studio e divulgazione scientifica.
Il patrimonio del Museo di Antropologia è vasto e variegato, spaziando da reperti osteologici a manufatti archeologici ed etnografici. Tra i pezzi più significativi troviamo la Collezione Craniologica di Giustiniano Nicolucci, che include crani con anomalie morfologiche e traumi, e calchi di crani provenienti dagli scavi di Pompei del 79 d.C., che offrono uno spaccato sulla vita e le condizioni delle popolazioni antiche. Di particolare interesse sono i calchi storici, come quello del cranio infantile di Australopithecus africanus e della calotta cranica di Homo erectus pekinensis, che documentano l’evoluzione umana.
Il museo è strutturato su tre sale, non molto grandi ma pregne di reperti, e vi è un progetto in fase di realizzazione che amplierà gli spazi espositivi. La prima sala, in particolare, si distingue per il confronto tra l’allestimento ottocentesco, basato sulla teoria delle “razze umane”, e un moderno pannello multimediale che promuove una visione scientifica aggiornata. Qui trovano spazio i calchi facciali di tipi somatici africani e asiatici realizzati da Lidio Cipriani, insieme a strumenti antropometrici d’epoca che testimoniano l’evoluzione delle metodologie di studio e la sconfessione di teorie che nulla avevano della dottrina della scienza. Il Cipriani, nel 1938, fu uno dei firmatari de “Il manifesto della razza”, un documento di propaganda razzista che, adducendo strumentalizzate “osservazioni scientifiche”, voleva ribadire l’inferiorità delle “razze umane” che non appartenessero ad un crisma occidentale e, soprattutto, di “pelle bianca”.
Il valore informativo, culturale e didattico di questa sezione viene messo a disposizione delle scolaresche che visitano frequentemente il museo.
Il museo ospita anche una collezione di reperti etnografici, come armi e utensili in pietra dell’America settentrionale, scudi e oggetti delle popolazioni indigene di Palawan (Filippine) e delle Andamane. Tra i reperti più prestigiosi spiccano i manufatti litici di Troia, donati nel 1879 dall’archeologo Heinrich Schliemann a Nicolucci, testimonianza dei legami tra il museo e le grandi scoperte archeologiche del XIX secolo.
E non si può non rimanere affascinati al cospetto delle quattro mummie sudamericane di epoca precolombiana, tra cui una mummia boliviana del 700 d.C. proveniente dalla zona di Tiwanaku, esposte nella terza sala del museo. I corpi mummificati sono stati abbigliati con tuniche in fibre di camelidi rappresentative delle diverse produzioni tessili delle culture precolombiane realizzate con tecniche di cucitura tipiche delle aree di provenienza dei reperti, e sono state collocate in un ambiente contestualizzato etnoculturalmente, in condizioni di umidità e temperatura controllate. I soggetti sono stati posti dagli imbalsamatori in posizione raccolta, fetale, emblematicamente per rappresentare il ritorno alle proprie origini nel viaggio ultraterreno.
Altra singolare esposizione è quella dedicata ai tatuaggi, “rimossi” post mortem da individui condannati e imprigionati per crimini violenti. Anche questa tecnica di “pseudo-studio” tendeva ad associare un nesso di causalità o comunque di correlazione fra il soggetto “antropologicamente criminale” e le sue azioni.
Scopo didattico del museo è anche quello di mostrare come gli studi scientifici,nel tempo, si siano evoluti e discostati da una filosofia di pensiero condizionata dal contesto sociale e culturale. Purtroppo, ancora oggi, nonostante i progressi scientifici, i pregiudizi restano latenti nella nostra struttura sociale. Basti ricordare la frase, razzista e dispregiativa, che tutti abbiamo ascoltato qualche volta: Ma non vedi? Glielo si legge in faccia che è un delinquente! Il Museo antropologico di Napoli si prefigge anche lo scopo di far comprendere quanto affermazioni del genere siano senza alcun fondamento scientifico. Una visita consigliata, come si legge sulle locandine dei film, “per tutta la famiglia”.
Per informazioni sugli orari e i costi per accedere al museo di Antropologia, basta visitare il sito istituzionale https://www.museiscienzenaturaliefisiche.it/it/musei/museo-di-antropologia.html
Di Massimiliano Del Prete