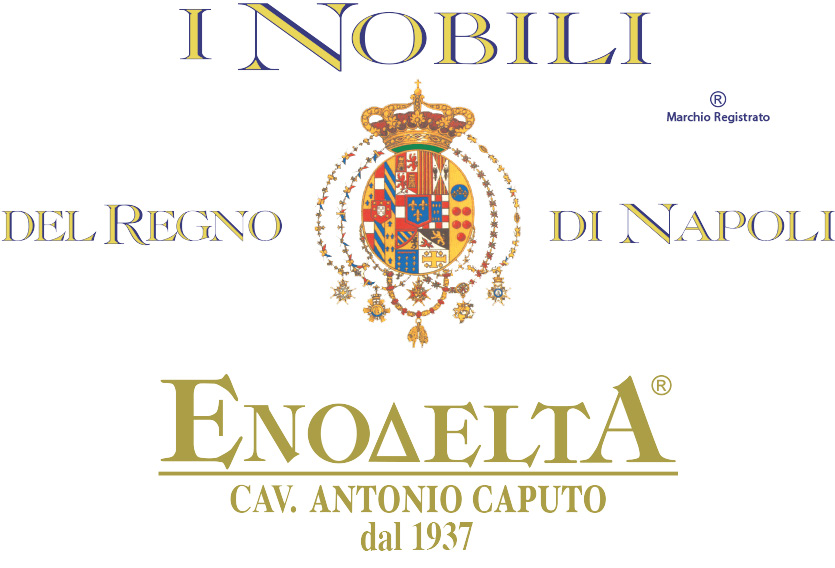di Alessandro Casillo
Il clamore politico segue il rumore dei fatti, ma cosa c’è dietro quel clamore? In un mondo che corre alla ricerca di soluzioni immediate, il dibattito sulla giustizia minorile riemerge con una proposta decisa, eppure inquietante: equiparare i reati dei minorenni a quelli dei maggiorenni. Un’idea che risuona come un atto di vendetta, un pugno duro che sembra dare risposta a un’opinione pubblica ferita, ma che, se analizzata, rivela tutta la sua debolezza e il suo sapore di mero consenso politico, specialmente da parte di un partito del Nord.
La scienza, però, ci dipinge un quadro diverso. Le neuroscienze dimostrano che un adolescente, pur sapendo distinguere tra bene e male, non possiede ancora gli strumenti cognitivi e la maturità emotiva di un adulto per gestire le proprie azioni. Affrontare il problema con una logica puramente punitiva è un po’ come voler curare una ferita senza disinfettarla: il rischio di infezione è altissimo. Il nostro sistema di giustizia minorile, con i suoi limiti, si fonda su un principio vitale: la rieducazione. L’obiettivo è recuperare un’anima “plasmabile” e darle una seconda possibilità, perché la punizione, senza un percorso di recupero, ha statisticamente dimostrato di aumentare il rischio di recidiva.
E qui sta il cuore del problema, una ferita che sanguina in silenzio: il disagio giovanile. I giovani che commettono questi reati non sono solo “cattivi ragazzi”, ma il prodotto di un sistema sociale che spesso li ha abbandonati. Povertà educativa, mancanza di punti di riferimento, contesti familiari difficili, assenza di opportunità: sono questi i semi da cui germinano atti disperati.
La verità è che l’ascesa politica su questi temi si fonda su un terreno arido, privo di vera conoscenza. È un’ondata di indignazione che si traduce in voti, senza affrontare la radice del male. La voglia di fare qualcosa c’è, ma mancano le basi, le competenze, la consapevolezza che la vera battaglia non si vince con pene più severe, ma investendo nella prevenzione. Dobbiamo puntare il dito non solo contro il reato, ma contro il fallimento sociale che lo ha generato.
E se ci fermassimo un attimo, se smettessimo di gridare alla vendetta e ascoltassimo il silenzio di un’adolescenza persa? Forse potremmo capire che la vera forza di una società non sta nella punizione, ma nella capacità di tendere una mano, di investire in educatori, psicologi, in progetti su misura. La speranza è che un giorno la politica si accorga che la prevenzione, la cura delle ferite sociali, sia un investimento molto più potente e duraturo di qualsiasi legge che sa solo punire. Perché l’unico vero modo per proteggere la nostra società è dare un futuro ai nostri giovani, non toglierglielo.