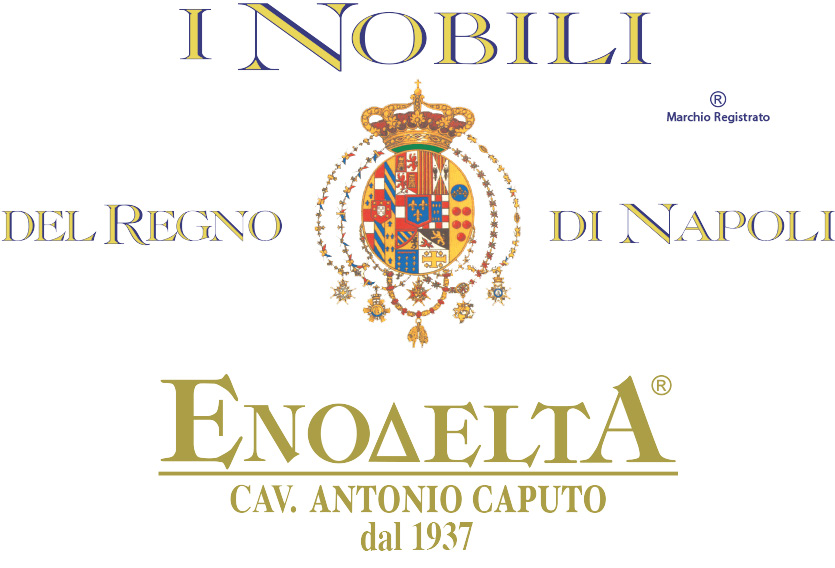di Alessandro Casillo
Nel cuore pulsante di Napoli, città vibrante di storia e meta ambita da un flusso turistico inarrestabile, si staglia un paradosso stridente. Mentre il settore ricettivo pullula di B&B, spesso accusati di alterare il tessuto sociale e residenziale, numerose strutture di ben più ampie dimensioni giacciono in un oblio desolante. Tra queste, spiccano gli scheletrici silenziosi di ex ostelli della gioventù, testimoni muti di un potenziale inespresso e di un’opportunità di sviluppo turistico di qualità colpevolmente trascurata. Questi edifici, un tempo pensato per accogliere gli ospiti desiderosi di esplorare le meraviglie partenopee con un occhio al budget, oggi rappresentano un costo silenzioso per la collettività. Sorvegliati, spesso a caro prezzo, per scongiurare occupazioni abusive o atti vandalici, non generano alcun beneficio, anzi, sottraggono risorse preziose che potrebbero essere investite altrove. In una città dove la domanda turistica è in costante crescita, la loro inattività appare come un’occasione mancata, un controsenso in un contesto che invoca a gran voce un miglioramento dei servizi e una diversificazione dell’offerta. Il dito viene puntato, con una certa insistenza, verso la proliferazione dei bed and breakfast, talvolta percepiti come una forma di sfruttamento intensivo del territorio che non sempre garantisce standard qualitativi elevati o un reale beneficio per l’economia locale diffusa.
Eppure, a pochi passi, strutture con una capacità ricettiva ben maggiore, capaci di ospitare un numero significativo di visitatori e di creare opportunità di lavoro stabili, rimangono avvolte nell’ombra dell’abbandono. Immaginare questi ex ostelli riqualificati e restituiti alla loro funzione originaria apre scenari promettenti. Potrebbero diventare poli di attrazione per un turismo giovanile e internazionale, desideroso di un’esperienza autentica e di un contatto più diretto con la cultura locale. Ostelli moderni e funzionali, dotati di servizi all’avanguardia e gestiti con professionalità, potrebbero non solo alleggerire la pressione sul mercato degli affitti a breve termine, ma anche contribuire ad elevare la qualità complessiva dell’offerta turistica napoletana. La riattivazione di queste strutture potrebbe innescare un circolo virtuoso: creazione di posti di lavoro, offerta di servizi turistici più strutturati, decongestione del centro storico e rivitalizzazione di aree urbane meno centrali. Un turismo più consapevole e distribuito sul territorio potrebbe beneficiare di alloggi a prezzi più accessibili, incoraggiando soggiorni più lunghi e una maggiore interazione con il tessuto sociale ed economico della città.
È tempo che Napoli volga lo sguardo a queste cattedrali silenziose del potenziale inespresso. Un piano strategico di recupero e riqualificazione di questi ex ostelli,attraverso investimenti pubblici e privati mirati, potrebbe rappresentare una risposta concreta alla crescente domanda turistica, offrendo al contempo opportunità di lavoro e un modello di ospitalità più sostenibile e di qualità. Ignorare ulteriormente questo patrimonio immobiliare significa non solo sprecare risorse economiche, ma anche rinunciare a un’occasione preziosa per plasmare un futuro turistico più equilibrato e inclusivo per la città.
CLICCA QUI PER SOSTENERE IL QUOTIDIANO L’IDENTITARIO
Napoli: Ostelli fantasma e l’enigma del turismo a due velocità