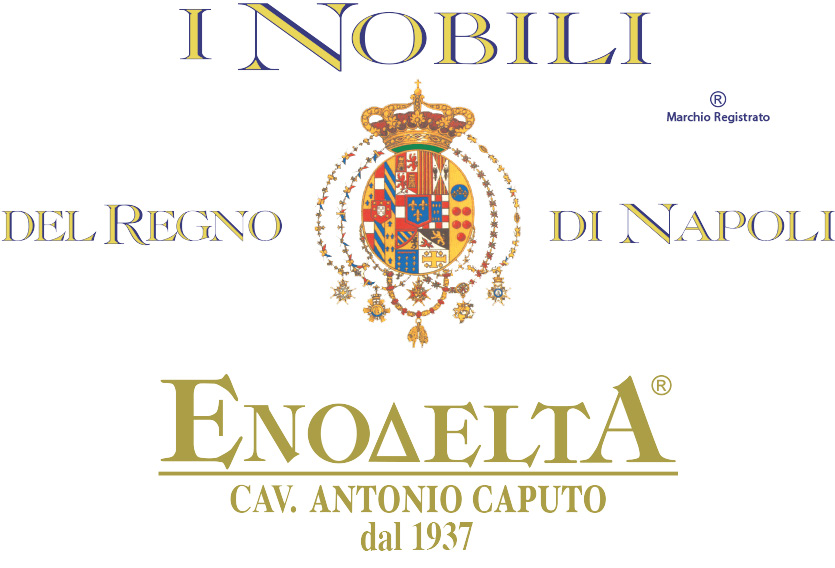Rubrica a cura di Enrico Fagnano: Il Mezzogiorno dopo l’Unità – Il regime fiscale nelle Due Sicilie e in Piemonte
Dalla contrapposta concezione che avevano sul ruolo dello Stato, di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, scaturiva una enorme differenza tra il Regno delle Due Sicilie e il Regno di Sardegna ed era quella che riguardava la pressione fiscale,
assai limitata nel primo e invece particolarmente pesante nel secondo. Il regno borbonico aveva un sistema estremamente agile, che prevedeva solo 5 tributi ed era caratterizzato da aliquote molto ridotte. Questo perché l’obbiettivo dell’amministrazione era di prelevare il minimo necessario per le proprie esigenze.
Nel 1859 i tributi erano: imposta fondiaria, dazi doganali (sulle merci in entrata e sulle merci in uscita) e dazi al consumo, tassa di bollo e di registro, tassa sulle lotterie e tassa postale. Come si vede, mancavano tra le altre la tassa sulle successioni, la
tassa sul macinato, progressivamente diminuita a partire dal 1831 e infine abolita con regio decreto il 13 agosto 1847, e l’imposta sulla ricchezza mobile, cioè sui redditi delle imprese e del commercio, talmente contenuta da poter essere considerata
semplicemente simbolica. Riguardo a quest’ultima, la scelta del governo napoletano
viene spiegata dall’economista lucano Francesco Saverio Nitti (più volte deputato e
ministro, nonché presidente del consiglio tra il 1919 e il 1920), il quale in Nord e Sud
(Roux e Viarengo, 1900) dice: ‘Non vi era quasi nessuna imposta sulla ricchezza
mobiliare. Poiché questa si andava formando, il cavaliere Medici e i suoi continuatori
aveano ritenuto che vi fosse pericolo grande a colpirla con imposte.’
La fondiaria era, quindi, l’imposta che dava il gettito maggiore, pari a 1/3 delle intere entrate, e si
calcolava, più o meno come oggi, sulla rendita catastale, che veniva tassata per il
13%, mentre nel Regno di Sardegna veniva tassata per il 20%. Per quanto riguarda i
dazi, ma nel campo industriale in linea di massima erano alti quelli in entrata e
contenuti quelli in uscita. Questo perché il governo borbonico praticava una politica
protezionistica, iniziata con i provvedimenti del 1823, per consentire alle imprese
meridionali di consolidarsi prima di andare a confrontarsi, come poi sarebbe stato
necessario, con quelle straniere. (Si tratta di una strategia tenuta da tutti gli Stati,
quando hanno avuto bisogno di sostenere lo sviluppo delle attività nazionali. La
applicheranno anche gli esecutivi italiani a partire dalla fine degli anni Settanta, come
vedremo, per tutelare il sistema interno, in quel momento ancora troppo fragile per
reggere la concorrenza estera).
Il Piemonte, invece, praticava il libero mercato, ma questo più che altro per compiacere l’Inghilterra, sua potente alleata, paladina di
questo tipo di politica economica, che favoriva le fabbriche d’oltremanica, più ricche
e progredite, consentendo alle stesse di vendere i propri prodotti in tutti gli altri paesi.
Nonostante il numero ridotto di tributi, nel 1859 il bilancio del Regno delle Due
Sicilie presentava circa 175 milioni di entrate, con uscite di pari importo. (Le entrate
erano costituite per 110 milioni da quelle del regno napoletano e per 17 milioni da
quelle della Sicilia, che aveva un’amministrazione autonoma, ma a queste cifre
bisognava aggiungere le spese di riscossione, pari a 14 milioni, calcolate a parte, nonché le entrate ordinarie e quelle patrimoniali, che portavano il totale complessivo appunto a 175 milioni. I dati sono indicati in lire piemontesi per consentire gli
opportuni raffronti.) Il pareggio era stato raggiunto all’inizio degli anni Quaranta e da
allora era stato perseguito con il massimo impegno da Ferdinando II, che lo
considerava un obbiettivo primario. Quanto fosse importante conseguirlo per il
sovrano borbonico si comprende, se si pensa a ciò che accadde dopo il 1848. In
quell’anno, tuttora ricordato per i disordini e le rivoluzioni nell’intera Europa, i conti
pubblici di tutti gli stati del continente finirono fuori controllo e questo accadde anche
nel Regno delle Due Sicilie, che chiuse il bilancio in passivo.
Decima puntata. I libri di Enrico Fagnano IL SUD DOPO L’UNITÀ e IL
PIEMONTESISMO E LA BUROCRAZIA IN ITALIA DOPO L’UNITÀ sono
disponibili sul sito Bottega2Sicilie: CLICCA QUI
Per ottenere
nuovamente il pareggio, quindi, il re chiese rigore in tutti i settori e per dare
l’esempio, prima di ogni altra cosa, sospese i propri compensi fino al conseguimento
dell’obbiettivo. A quel punto non potettero fare a meno di imitarlo i suoi ministri e, di
seguito, i titolari delle principali cariche amministrative. Anche all’epoca, si può
starne certi, sarebbe stato difficile trovare in un altro Stato una classe dirigente così
seriamente impegnata, addirittura con una partecipazione personale, nelle proprie
funzioni. L’anno successivo logicamente i conti furono nuovamente in ordine.
Il Piemonte in tutto aveva 23 tributi, che, oltre alla già citata fondiaria, erano: dazi
doganali, imposta personale, tassa sulle successioni, tassa sulle donazioni e sui mutui,
tassa sulle doti, sull’emancipazione e sull’adozione, tassa sulle pensioni, tassa
sanitaria, tassa sulle fabbriche, tassa sull’industria, tassa sulle società industriali, tassa
sui pesi e sulle misure, diritto d’insinuazione, diritto di esportazione della paglia,
diritto sul consumo delle carni, delle pelli, dell’acquavite e della birra, tassa sulle
mani morte, tassa per la caccia, tassa sulle vetture e tassa sulla carta bollata. Come si
vede, c’erano tasse praticamente su tutto e c’erano anche incredibili sovrapposizioni.
Con questi tributi il Regno di Sardegna realizzava 144 milioni di entrate, mentre dal
1855 in poi, come sappiamo, non fu più possibile contabilizzare le uscite. In
conclusione, per quanto riguarda la media dei prelievi, nel Regno delle Due Sicilie un
contribuente pagava circa 13 lire all’anno e nel regno subalpino circa 35 lire, mentre,
per quanto riguarda la pressione fiscale, nel primo era di circa il 20% sul reddito e nel
secondo arrivava quasi al 50%. Questo significa che nel Sud la ricchezza prodotta da
ogni cittadino in buona misura rimaneva nella sua disponibilità, mentre in Piemonte
per circa la metà veniva prelevata dall’amministrazione pubblica. Di conseguenza
nello Stato meridionale i benestanti erano veramente tali, mentre anche i borghesi
potevano concedersi qualche lusso, cosa che certo non succedeva negli altri Stati
italiani (e per la verità neanche nella maggior parte di quelli europei), e tale
situazione, come è facile immaginare, aveva ricadute su molte attività, specialmente
nel Napoletano.
Dal momento che la ricchezza mobile praticamente non era tassata, gli investimenti
industriali nelle Due Sicilie producevano interessanti remunerazioni e gli utili (come
ricorda lo storico dell’imprenditoria Angelo Mangone ne L’Industria del Regno di
Napoli 1859-1860, Fiorentino, 1976) generalmente erano del 7-8%, ma nei casi delle
strutture più moderne e organizzate potevano arrivare fino al 20%. Di conseguenza i
sudditi dei Borbone che detenevano capitali, per lo più appartenenti alla nobiltà,
erano spinti a trasformarsi in imprenditori. Anzi in breve questa divenne una vera e
propria tendenza, per non dire mania, che coinvolse chiunque avesse disponibilità
economica e dopo l’Unità ci vollero, come vedremo, quasi trenta anni e numerosi
provvedimenti, sia amministrativi, sia legislativi, per debellare l’attitudine agli affari
e agli investimenti dei Meridionali.
Delle imprese sorte nel regno ad opera di capitalisti del Sud prima del 1860 parla ne
La Provincia e la città di Napoli (Morano, 1902) lo studioso campano Francesco
Paolo Rispoli, il quale tra l’altro scrive: ‘Banca e commercio avevano siffattamente
sviluppato la marina mercantile che sorsero numerose e rigogliose società di
assicurazioni marittime di cui mi piace ricordare qualcuna: Compagnia di
Assicurazioni Generali del Sebeto, L’Ancora, Compagnia Anonima Torrese, Urania,
Società di Assicurazioni Flavio Gioia e Società Anonima di assicurazioni marittime.
E tutte queste società, come la maggior parte di quelle che verrò citando in seguito,
erano formate da napoletani con capitali napoletani.’ Non diversamente, comunque,
stavano le cose anche negli altri settori della finanza e dell’economia.
(Il regime fiscale nelle Due Sicilie e in Piemonte)
Decima puntata. I libri di Enrico Fagnano IL SUD DOPO L’UNITÀ e IL
PIEMONTESISMO E LA BUROCRAZIA IN ITALIA DOPO L’UNITÀ sono
disponibili sul sito Bottega2Sicilie: CLICCA QUI
SOSTIENI E SEGUI IL QUOTIDIANO L’IDENTITARIO